Roma, 22 gennaio 2021
Pioggia
Il numero del 22 gennaio 2021
Tema
Se c’è un oggetto che non deve mai mancare nello zaino di un escursionista questo è la mantellina. In montagna il tempo è davvero mutevole e il temporale può sempre arrivare. La pioggia può anche essere una benedizione, ma sui sentieri, per uno che cammina, é davvero fastidiosa. Qualcuno si limita all’ombrello, ma quello può far pensare ad Altan ed al suo Cipputi e dunque contro la pioggia meglio la mantellina.

colonna sonora
È la pioggia che va de The Rokes (1966)
proposta da Pino
Svolgimento

pensieri
Appena infatti ebbe Renzo passata la soglia del lazzeretto e preso a diritta, per ritrovar la viottola di dov’era sboccato la mattina sotto le mura, principiò come una grandine di goccioloni radi e impetuosi, che, battendo e risaltando sulla strada bianca e arida, sollevavano un minuto polverìo; in un momento, diventaron fitti; e prima che arrivasse alla viottola, la veniva giù a secchie. Renzo, in vece d’inquietarsene, ci sguazzava dentro, se la godeva in quella rinfrescata, in quel susurrìo, in quel brulichìo dell’erbe e delle foglie, tremolanti, gocciolanti, rinverdite, lustre; metteva certi respironi larghi e pieni; e in quel risolvimento della natura sentiva come più liberamente e più vivamente quello che s’era fatto nel suo destino.
Ma quanto più schietto e intero sarebbe stato questo sentimento, se Renzo avesse potuto indovinare quel che si vide pochi giorni dopo: che quell’acqua portava via il contagio; che, dopo quella, il lazzeretto, se non era per restituire ai viventi tutti i viventi che conteneva, almeno non n’avrebbe più ingoiati altri; che, tra una settimana, si vedrebbero riaperti usci e botteghe, non si parlerebbe quasi più che di quarantina; e della peste non rimarrebbe se non qualche resticciolo qua e là; quello strascico che un tal flagello lasciava sempre dietro a sé per qualche tempo.
Alessandro Manzoni, I Promessi sposi, Capitolo XXXVII
Gli indigeni, pur dotati di un forte senso del ritmo, non conoscono affatto la poesia, o almeno non la conoscevano finché non furono aperte le scuole, dove impararono gli inni. Una sera, mentre stavamo raccogliendo il granoturco e ammassando le pannocchie sui carri, cominciai per divertirmi a comporre versi in suaheli per i giovanissimi contadini indigeni. Erano versi senza senso, fatti solo per la rima: – “Ngumbe na-penda chumbe, Malaya mbaya. Wakamba na-kula mamba.” I buoi sono come il sale – le sgualdrine cattive – i Wakamba mangiano serpi. I ragazzi drizzarono subito le orecchie, venendo a farmi cerchio intorno. Intuirono immediatamente che in poesia il contenuto non conta e non stettero a chiedermi cosa significassero i miei versi; aspettavano ansiosamente la rima e, ogni volta, si mettevano a ridere. Li esortai a trovarla loro stessi, finendo le poesie cominciate da me; ma non riuscivano, o non volevano, e voltavano la testa dall’altra parte. Quando si furono abituati all’idea, cominciarono a implorarmi: “Parlami ancora. Parla come la pioggia.” Perché la poesia li facesse pensare alla pioggia, non lo so. Ma doveva essere un segno d’ammirazione, perché la pioggia, in Africa, è sempre bramata e accolta con gioia.»
Karen Blixen, La mia Africa, Feltrinelli
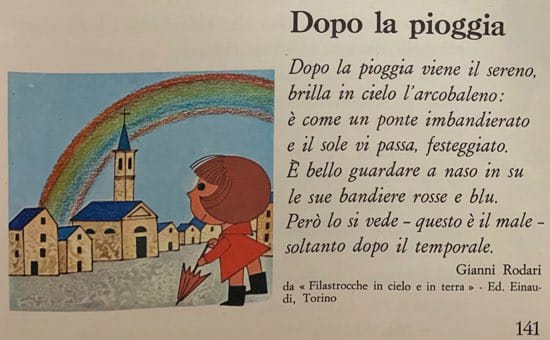
L’universalismo culturale europeo, sosteneva Moravia, come un temporale improvviso, imbeve di tanto in tanto un territorio disegnato da confini, frontiere, limiti di proprietà. Ma questa pioggia fecondante è tutt’altro che tranquilla, è invece esplosiva e drammatica.
Paolo Di Paolo

arguzie
A #gennaio: sotto la #neve pane, sotto la #pioggia fame.
@ItalyGreenLife·8 gen
Non può piovere per tutta la vita.
Gabriel García Márquez, Cent’anni di solitudine
@FrancescoPacia·9 gen

Il meteo del Tg3 è sotto accusa per l’eccessivo rilievo dato alle perturbazioni in arrivo. Il governo mette sotto accusa la totale assenza di contraddittorio, e chiede che durante il meteo sia presente in studio un esponente della maggioranza che sostenga le ragioni dell’anticiclone. “Ai comunisti piace la pioggia, a noi la figa”, ha detto sorridendo il premier per sdrammatizzare. La riforma del meteo non è il solo provvedimento contenuto nel lodo Ghedini, che la maggioranza conta di fare approvare dal Capo dello Stato imitandone la firma. “Bonaiuti la fa quasi uguale”, ha spiegato Berlusconi per abbassare i toni della polemica.
Michele Serra, Satira preventiva – Al Tg3 c’è un meteo faziosissimo, L’Espresso del 2 ottobre 2009
tante parole, il testo lungo
La pioggia che ristora e che, se esagera, distrugge. La natura che non si arrende alla grigia città e che soccombe al troppo!
La pioggia e le foglie
In ditta, tra le varie altre incombenze, a Marcovaldo toccava quella d’innaffiare ogni mattina la pianta in vaso dell’ingresso. Era una di quelle piante verdi che si tengono in casa, con un fusto diritto ed esile da cui si staccano, da una parte e dall’altra, su lunghi gambi foglie larghe e lucide: insomma, una di quelle piante così a forma di pianta, con foglie così a forma di foglia, che non sembrano vere. Ma era pur sempre una pianta, e come tale soffriva, perché a star lì, tra la tenda e il portaombrelli, le mancavano luce, aria e rugiada. Marcovaldo ogni mattina scopriva qualche brutto segno: a una foglia il gambo s’inclinava come se non ce la facesse più a reggere il peso, un’altra s’andava picchiettando di chiazze come la guancia d’un bambino col morbillo, la punta d’una terza ingialliva; finché, una o l’altra, taci, la si trovava in terra. Intanto (quel che più stringeva il cuore) il fusto della pianta s’allungava, s’allungava, non più ordinatamente fronzuto, ma nudo come un bastone, con un ciuffetto in cima che la faceva somigliare a un palmizio.
Marcovaldo sgomberava il pavimento dalle foglie cadute, spolverava quelle sane, versava a pie della pianta (lentamente, che non traboccasse sporcando le piastrelle) mezzo annaffiatoio d’acqua, subito bevuto dalla terra del vaso. E in questi semplici gesti metteva un’attenzione come in nessun altro suo lavoro, quasi una compassione per le disgrazie d’una persona di famiglia. E sospirava, non si sa se per la pianta o per sé: perché in quell’arbusto che ingialliva allampanato tra le pareti aziendali riconosceva un fratello di sventura.
La pianta (così, semplicemente, essa era chiamata, come se ogni nome più preciso fosse inutile in un ambiente in cui a essa sola toccava di rappresentare il regno vegetale) era entrata nella vita di Marcovaldo tanto da dominare i suoi pensieri in ogni ora del giorno e della notte. Lo sguardo con cui egli ora scrutava in ciclo l’addensarsi delle nuvole, non era più quello del cittadino che si domanda se deve o no prendere l’ombrello, ma quello dell’agricoltore che di giorno in giorno aspetta la fine della siccità. E appena, alzando il capo dal lavoro, scorgeva controluce, fuor della finestrella del magazzino, la cortina di pioggia che aveva cominciato a scendere fitta e silenziosa, lasciava lì tutto, correva alla pianta, prendeva in braccio il vaso e lo posava fuori, in cortile.
La pianta, a sentir l’acqua che le scorreva per le foglie, pareva espandersi per offrire più superficie possibile alle gocce, e dalla gioia colorarsi del suo verde più brillante: o almeno così sembrava a Marcovaldo che si fermava a contemplarla dimenticando di mettersi al riparo.
Restavano lì in cortile, uomo e pianta, l’uno di fronte all’altra, l’uomo quasi provando sensazioni da pianta sotto la pioggia, la pianta – disabituata all’aria aperta e ai fenomeni della natura – sbalordita quasi quanto un uomo che si trovi tutt’a un tratto bagnato dalla testa ai piedi e coi vestiti zuppi. Marcovaldo, a naso in su, assaporava l’odore della pioggia, un odore – per lui – già di boschi e di prati, e andava inseguendo con la mente dei ricordi indistinti. Ma tra questi ricordi s’affacciava, più chiaro e vicino, quello dei dolori reumatici che lo affliggevano ogni anno; e allora, in fretta, ritornava al coperto.
Finito l’orario di lavoro, bisognava chiudere la ditta. Marcovaldo chiese al magazziniere-capo: – Posso lasciar fuori la pianta, lì in cortile? Il capo, signor Viligelmo, era un tipo che rifuggiva dalle responsabilità troppo onerose. – Sei matto? E se la rubano? Chi è che ne risponde?
Marcovaldo però, a vedere il profitto che la pianta traeva dalla pioggia, non si sentiva di rimetterla al chiuso: sarebbe stato sprecare quel dono del ciclo. – Potrei tenerla con me fino a domattina… – propose. – La carico sul portapacchi e me la porto a casa… Così le faccio prendere più pioggia che si può… Il signor Viligelmo ci pensò un poco, poi concluse: Vuoi dire che ne rispondi tu, – e assentì.
Marcovaldo attraversava la città sotto la pioggia dirotta, curvo sul manubrio della sua bicicletta a motore, incappucciato in una giacca-a-vento impermeabile. Dietro, sul portapacchi, aveva legato il vaso, e bici uomo pianta parevano una cosa sola, anzi l’uomo ingobbito e infagottato scompariva, e si vedeva solo una pianta in bicicletta. Ogni tanto, da sotto il cappuccio, Marcovaldo voltava indietro lo sguardo fino a veder sventolare dietro le sue spalle una foglia stillante: e ogni volta gli pareva che la pianta fosse diventata più alta e più fronzuta.
A casa – una mansarda col davanzale sui tetti – appena Marcovaldo arrivò col vaso tra le braccia, i bambini presero a fare girotondo.
L’albero di Natale! L’albero di Natale!
Ma no, cosa vi viene in mente? C’è tempo a Natale! – protestava Marcovaldo. – Attenti alle foglie che sono delicate!
Già in questa casa ci stiamo come in una scatola di sardine, – brontolò Domitilla. – Se ci porti pure un albero, dovremo uscire noi…
Ma se è una piantina! La metto sul davanzale…
L’ombra della pianta sul davanzale si poteva vedere dalla stanza. Marcovaldo a cena non guardava nel piatto ma oltre i vetri della finestra.
Da quando avevano lasciato il seminterrato per la mansarda, la vita di Marcovaldo e famiglia era migliorata di molto. Però anche l’abitare sotto i tetti aveva i suoi inconvenienti: il soffitto per esempio lasciava colare qualche goccia. Le gocce cadevano in quattro o cinque punti ben precisi, a intervalli regolari; e Marcovaldo vi metteva sotto bacinelle o casseruole. Le notti di pioggia quando tutti erano a letto, si sentiva il tic–toc–tuc dei vari gocciolii, che dava un brivido come per un presagio di reumatismi. Quella notte, invece, a Marcovaldo, ogni volta che nel suo sonno inquieto si svegliava e tendeva l’orecchio, il tic–toc–tuc pareva una musichetta allegra: gli diceva che la pioggia continuava, blanda e ininterrotta, e nutriva la pianta, spingeva la linfa su per gli esili peduncoli, tendeva le foglie come vele. «Domani, affacciandomi, la troverò cresciuta!» pensava.
Ma con tutto che l’avesse pensato, aprendo la finestra al mattino non poteva credere ai suoi occhi: la pianta ora ingombrava mezza finestra, le foglie erano per lo meno raddoppiate di numero, e non più reclinate sotto il loro peso ma tese e aguzze come spade. Scese le scale col vaso stretto al petto, lo legò al portapacchi e corse in ditta. Era spiovuto, ma la giornata rimaneva incerta. Marcovaldo non era ancora sceso di sella, quando riprese a cascare qualche goccia. «Visto che le fa così bene, la lascio ancora in cortile» pensò lui.
In magazzino, ogni tanto andava a mettere il naso fuori della finestrella che dava sul cortile. Questo suo distrarsi dal lavoro, al magazziniere–capo non garbava. – Be’, cosa ci hai oggi, da guardare fuori?
Cresce! Venga a vedere anche lei, signor Viligelmo! – e Marcovaldo gli faceva cenno con la mano, e parlava quasi sottovoce, come se la pianta non dovesse accorgersene.
Guardi come cresce! Neh, che è cresciuta?
Sì, è cresciuta un bel po’, – ammise il capo, e per Marcovaldo fu una di quelle soddisfazioni che la vita in ditta riserva ben di rado al personale. Era sabato. Il lavoro terminava all’una e fino al lunedì non si tornava. Marcovaldo avrebbe voluto riprendere la pianta con sé, ma ormai, non piovendo più, non sapeva che scusa trovare. Il cielo però non era sgombro: nubi nere, a cumuli, erano sparse un po’ qua e un po’ là. Andò dal capo, che, appassionato di meteorologia, teneva appeso sopra il suo tavolo un barometro.
Come si mette, signor Viligelmo?
Brutto, sempre brutto, – lui disse. – Del resto, qui non sta piovendo, ma nel quartiere dove abito sì: ho telefonato ora a mia moglie.
Allora, – s’affrettò a proporre Marcovaldo, – io porterei la pianta a fare un giro dove piove, – e detto fatto tornò a sistemare il vaso sul portapacchi della bici. Il sabato pomeriggio e la domenica, Marcovaldo li passò in questo modo: caracollando sul sellino della sua bicicletta a motore, con la pianta dietro, scrutava il cielo, cercava una nuvola che gli sembrasse ben intenzionata, e correva per le vie finché non incontrava pioggia. Ogni tanto, voltandosi, vedeva la pianta un po’ più alta: alta come i taxi, come i camioncini, come i tram! E con le foglie sempre più larghe, dalle quali la pioggia scivolava sul suo cappuccio impermeabile come da una doccia.
Ormai era un albero su due ruote, quello che correva la città disorientando vigili guidatori pedoni. E le nuvole, nello stesso tempo, correvano le vie del vento, sventagliavano di pioggia un quartiere e poi l’abbandonavano; e i passanti uno a uno sporgevano la mano e richiudevano gli ombrelli; e, per vie e corsi e piazze, Marcovaldo rincorreva la sua nuvola, curvo sul manubrio, imbacuccato nel cappuccio da cui sporgeva solo il naso, col motorino scoppiettante a tutto gas, tenendo la pianta nella traiettoria delle gocce, come se lo strascico di pioggia che la nuvola si tirava dietro si fosse impigliato alle foglie e così tutto corresse trascinato dalla stessa forza: vento nuvola pioggia pianta ruote.
Il lunedì Marcovaldo si presentò al signor Viligelmo a mani vuote.
E la pianta? – chiese subito il magazziniere-capo.
È fuori. Venga.
Dove? – fece Viligelmo. – Non la vedo.
È quella lì. È cresciuta un po’… – e indicò un albero che arrivava al secondo piano. Era piantato non più nel vecchio vaso ma in una specie di barile, e al posto della bicicletta Marcovaldo aveva dovuto procurarsi un motociclo a furgoncino.
E adesso? – s’infuriò il capo. –-Come possiamo farla stare nell’ingresso? Non passa più dalle porte!
Marcovaldo si strinse nelle spalle.
L’unica, –-disse Viligelmo, – è restituirla al vivaio in cambio d’un’altra dalle dimensioni giuste!
Marcovaldo rimontò in sella. – Vado.
Ricominciò la corsa per la città. L’albero riempiva di verde il centro delle vie. I vigili, preoccupati per il traffico, lo fermavano a ogni incrocio; poi – quando Marcovaldo spiegava che stava riportando la pianta al vivaio per toglierla di mezzo – lo lasciavano proseguire. Ma, gira gira, Marcovaldo la strada del vivaio non si decideva a imboccarla. Di separarsi dalla sua creatura, ora che l’aveva tirata su con tanta fortuna, non aveva cuore: nella sua vita gli pareva di non aver mai avuto tante soddisfazioni come da questa pianta.
E così continuava a far la spola per vie e piazze e lungofiumi e ponti. E una verzura da foresta tropicale dilagava fino a coprirgli la testa le spalle le braccia, fino a farlo scomparire nel verde. E tutte queste foglie e gambi di foglia ed anche il fusto (che era rimasto sottilissimo) oscillavano oscillavano come per un continuo tremito, sia che scrosci di pioggia ancora scendessero a percuoterli, sia che le gocce si facessero più rade, sia che s’interrompessero del tutto.
Spiovve. Era l’ora verso il tramonto. In fondo alle vie, nello spazio tra le case, si posò una luce confusa d’arcobaleno. La pianta, dopo quell’impetuoso sforzo di crescita che l’aveva tesa finché durava la pioggia, si trovò come sfinita. Marcovaldo continuando la sua corsa senza meta non s’accorgeva che dietro di lui le foglie a una a una passavano dal verde intenso al giallo, un giallo d’oro.
Già da un pezzo, un corteo di motorette e auto e bici e ragazzi s’era messo a seguire l’albero che passava per la città, senza che Marcovaldo se ne fosse accorto, e gridavano: – II baobab! Il baobab! – e con grandi: – Oooh! – d’ammirazione seguivano l’ingiallire delle foglie. Quando una foglia si staccava e volava via, molte mani s’alzavano per coglierla al volo.
Prese a tirare vento; le foglie d’oro, a raffiche, correvano via a mezz’aria, volteggiavano.
Marcovaldo ancora credeva d’avere alle spalle l’albero verde e folto, quando a un tratto –forse sentendosi nel vento senza riparo – si voltò. L’albero non c’era più: solo uno smilzo stecco da cui si dipartiva una raggerà di peduncoli nudi, e ancora un’ultima foglia gialla là in cima. Alla luce dell’arcobaleno tutto il resto sembrava nero: la gente sui marciapiedi, le facciate delle case che facevano ala; e su questo nero, a mezz’aria, giravano giravano le foglie d’oro, brillanti, a centinaia; e mani rosse e rosa a centinaia s’alzavano dall’ombra per acchiapparle; e il vento sollevava le foglie d’oro verso l’arcobaleno là in fondo, e le mani, e le grida; e staccò anche l’ultima foglia che da gialla diventò color d’arancio poi rossa violetta azzurra verde poi di nuovo gialla e poi sparì.
Italo Calvino, Marcovaldo, Einaudi
